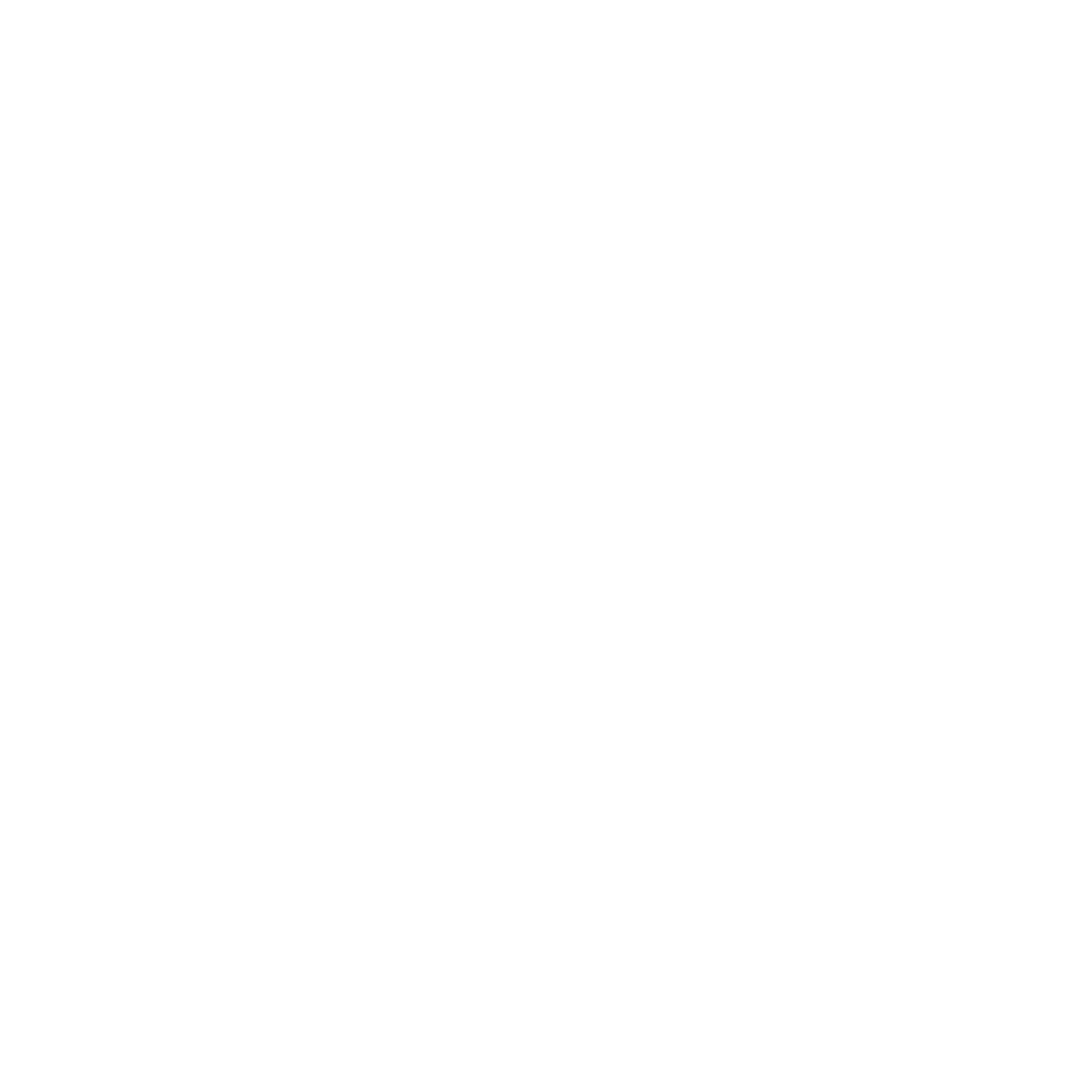Le notizie dal mondo questa volta ci riguardano molto da vicino. Diplodoma giulioregenii è una specie di microlepidottero appartenente alla famiglia Psychidae, descritta per la prima volta da Sara La Cava e Stefano Scalercio nel 2025. La scoperta è avvenuta nei boschi della provincia di Cosenza, in Calabria, nell’ambito del progetto National Biodiversity Future Centre (NBFC) finanziato dal PNRR.
Contenuti dell'articolo
La denominazione della specie è un omaggio a Giulio Regeni, giovane ricercatore italiano tragicamente ucciso nel 2016; il team di ricerca, composto in gran parte da dottorandi della stessa età, ha scelto questo gesto significativo per mantenerne viva la memoria.
Le farfalle “costruttrici di sacchetti”: la famiglia Psychidae
Introduzione
La famiglia Psychidae è un gruppo di microlepidotteri appartenenti alla superfamiglia Tineoidea, noti in inglese come bagworm moths. Il nome comune deriva dal comportamento larvale: i bruchi costruiscono un astuccio (“sacchetto”) con seta e materiali vegetali, che trasportano per tutta la vita e che offre protezione dai predatori e dalle condizioni ambientali.
Nel mondo sono state descritte oltre 1.350 specie di Psychidae, distribuite in tutti i continenti, con una maggiore diversità nelle regioni temperate e tropicali.
Morfologia e dimorfismo sessuale
Il tratto più sorprendente dei Psychidae è il forte dimorfismo sessuale:
- I maschi sono alati, di piccole dimensioni (apertura alare 8–35 mm), con antenne spesso bipectinate, e conducono una vita breve dedicata alla ricerca delle femmine.
- Le femmine, invece, sono in molte specie attere e vermiformi, prive di ali e talvolta incapaci di lasciare il loro astuccio.
Questa differenza è un adattamento estremo che riduce la mobilità delle femmine ma ne aumenta la sopravvivenza, mentre i maschi garantiscono la dispersione genetica.
Biologia ed ecologia

Le larve vivono dentro i loro astucci, che vengono continuamente ingranditi con materiali raccolti nell’ambiente: foglie secche, licheni, frammenti di corteccia. Questo li rende mimetici e difficili da individuare.
La dieta varia a seconda delle specie: molte sono fitofaghe generaliste, altre sono specializzate su muschi o licheni. In genere svolgono un ruolo ecologico importante come riciclatori di materia organica.
Alcuni Psychidae hanno anche rilevanza economica: ad esempio, Metisa plana è un serio parassita delle piantagioni di palma da olio in Malesia, mentre Mahasena corbetti danneggia piantagioni di tè e caffè in Sri Lanka e India.
Riproduzione e strategie adattative
La riproduzione avviene spesso in modo insolito:
- Le femmine rilasciano feromoni restando all’interno dell’astuccio.
- I maschi le raggiungono e avviene la fecondazione senza che la femmina si muova.
- Le uova vengono deposte dentro lo stesso sacchetto materno, che diventa così il primo rifugio per la prole.
In alcune specie è stata osservata anche partenogenesi, cioè la capacità delle femmine di riprodursi senza fecondazione maschile.
Diversità e classificazione
La famiglia è suddivisa in diverse sottofamiglie, tra cui:
- Psychinae (con specie diffuse in Europa, come Psyche casta),
- Oiketicinae (che include specie tropicali di grandi dimensioni, come Oiketicus kirbyi),
- Taleporiinae (con piccoli costruttori di astucci cilindrici, come Taleporia tubulosa).
Gli studi genetici più recenti hanno rivelato che molte popolazioni, considerate uniche, appartengono a complessi di specie criptiche, distinguibili solo attraverso il DNA barcoding.
Ruolo ecologico e conservazione
Gli Psychidae sono indicatori ambientali preziosi: la loro presenza e abbondanza riflette la qualità degli ecosistemi forestali e dei microhabitat in cui vivono. In alcune regioni europee e mediterranee diverse specie sono considerate rare o minacciate, a causa della frammentazione degli habitat e dell’urbanizzazione.
La loro biologia peculiare, con femmine incapaci di volare e larve strettamente dipendenti dall’habitat, li rende particolarmente vulnerabili ai cambiamenti ambientali.
La ricerca su Diplodoma giulioregenii

Caratteristiche morfologiche
Gli esemplari raccolti presentano un’apertura alare di circa 12–13 mm. Come altre specie del genere Diplodoma, si tratta di farfalle di piccole dimensioni e aspetto poco appariscente, caratterizzate da ali grigio-marroni.
La vera differenza rispetto ad altre specie si osserva negli organi genitali maschili, che in Lepidoptera sono fondamentali per distinguere specie molto simili. In D. giulioregenii il phallus (organo copulatore) è lungo circa 708 µm, sottile, leggermente curvo e provvisto di quattro denti distali; la valva è corta e sclerotizzata, con apice arrotondato ricoperto di setole.
Analisi genetiche
Per confermare che non si trattasse di una popolazione già nota, i ricercatori hanno analizzato il gene mitocondriale COI, utilizzato nel cosiddetto “DNA barcoding”. I risultati hanno mostrato una distanza genetica di circa 6,25% dalla specie più simile (Diplodoma laichartingella), un valore che rientra ampiamente nei limiti tipici per differenziare specie distinte.
Ecologia e habitat
Gli individui sono stati rinvenuti in boschi misti di conifere e latifoglie (pino, faggio, castagno). Si ipotizza che, come altri Psychidae, le larve si nutrano di licheni, muschi e foglie secche, costruendo piccoli astucci protettivi in cui vivono e si sviluppano.
Questi insetti hanno un ruolo importante negli ecosistemi, contribuendo al riciclo della materia organica e al mantenimento della biodiversità forestale.
Significato scientifico e simbolico
La scoperta di D. giulioregenii ha un duplice valore:
- Scientifico, perché conferma la ricchezza della fauna entomologica italiana, in particolare nelle foreste della Calabria, considerate veri “hotspot” di biodiversità europea.
- Umano e simbolico, perché il nome scelto rende omaggio a Giulio Regeni, trasformando una scoperta biologica in un gesto di memoria civile e collettiva.
Conclusioni
Diplodoma giulioregenii dimostra che anche nei territori europei, spesso ritenuti “ben conosciuti”, esiste ancora una biodiversità nascosta da studiare e proteggere. Questa piccola farfalla diventa così emblema di scienza, memoria e tutela della natura.
Riferimenti bibliografici
La Cava S., Scalercio S. (2025). Descrizione di Diplodoma giulioregenii sp. nov. da habitat forestali del Sud Italia. Zootaxa. (“Revisiting the genus Diplodoma … DNA barcoding…”).
Comunicato CREA: scoperta della nuova specie nel contesto NBFC – Zootaxa
Approfondimenti giornalistici e divulgativi su D. giulioregenii (Wired Italia, Il Fatto Quotidiano, LifeGate, ANSA)
Dettagli morfometrici della specie e differenze genitali (agenparl / Zootaxa figg.)
Kristensen, N.P. (2003). Lepidoptera, moths and butterflies. Volume 2: Morphology, physiology, and development. Handbook of Zoology. Walter de Gruyter.
Mutanen, M., Wahlberg, N., Kaila, L. (2010). Comprehensive gene and taxon coverage elucidates radiation patterns in moths and butterflies. Proceedings of the Royal Society B: Biological Sciences, 277(1695), 2839–2848.
Rhainds, M., Davis, D.R., Price, P.W. (2009). Bionomics of bagworms (Lepidoptera: Psychidae). Annual Review of Entomology, 54, 209–226.
Sauter, W., Hättenschwiler, P. (1991). The life history and ecology of Dahlica triquetrella (Hübner) (Lepidoptera, Psychidae) in Switzerland. Mitteilungen der Schweizerischen Entomologischen Gesellschaft, 64, 293–306.
Sobczyk, T. (2011). World Catalogue of Insects. Volume 10: Psychidae (Lepidoptera). Apollo Books, Stenstrup.
Stehr, F.W. (1987). Immature Insects. Vol. 1. Kendall/Hunt Publishing Company, Dubuque.