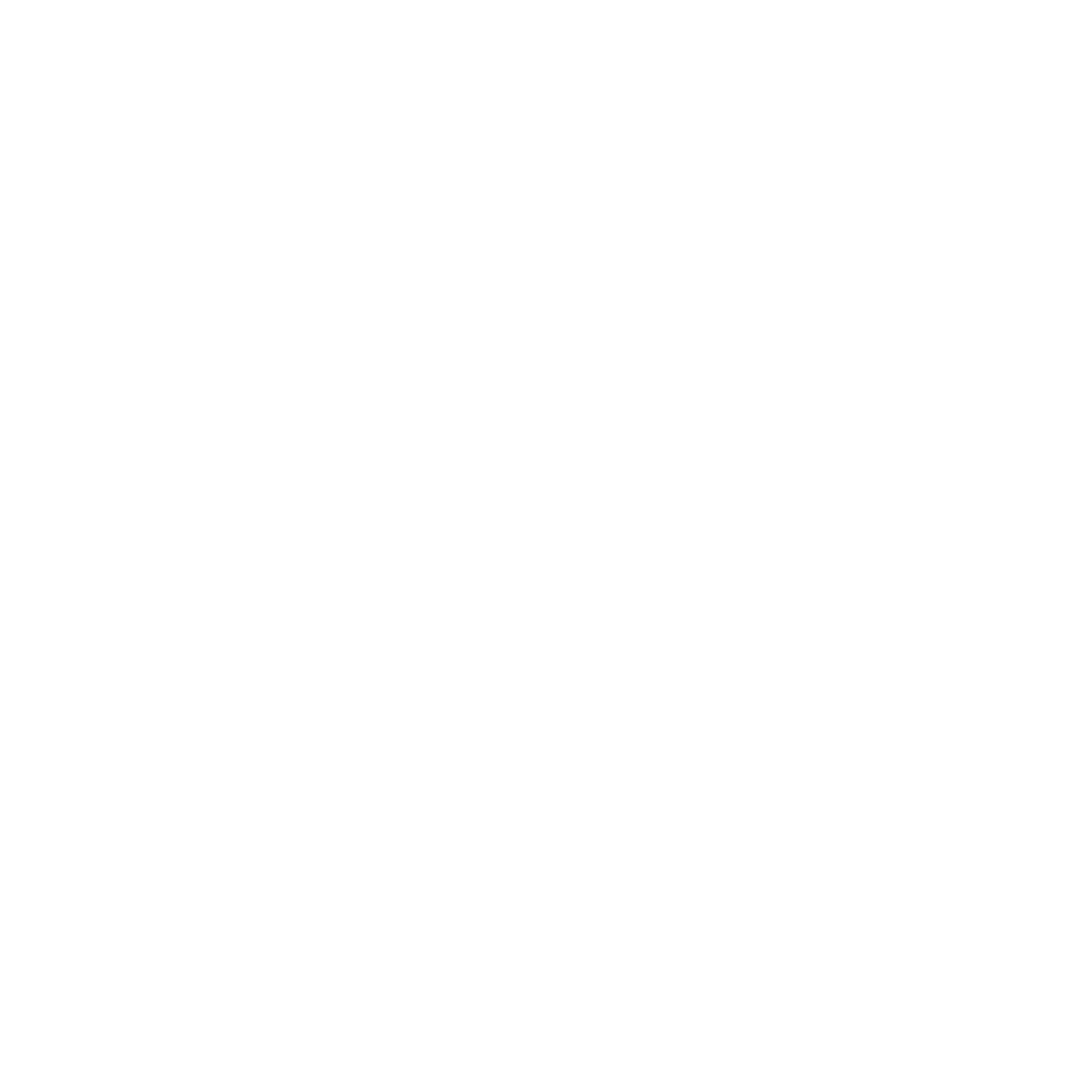La Spatola bianca appartiene alla famiglia Threskiornithidae (ibis e spatole). È un grande trampoliere, completamente bianco, con becco lungo e spatolato nero (punta gialla negli adulti in abito nuziale), zampe nere, e un pennacchio nucale erettile nel periodo riproduttivo; petto con suffusione giallastra durante la stagione degli amori. Apertura alare 115–135 cm, massa 1,2–1,9 kg. Lo status globale è Least Concern (LC), con areale eurasiatico-africano molto ampio.
Contenuti dell'articolo

Ecologia alimentare e comportamento della spatola bianca
Specie tipicamente limnofila ed estuarina, frequenta acque basse (fino a ~40 cm) in lagune, saline, piane tidali, canneti e vasche di colmata. L’alimentazione è tattile: procede lentamente nell’acqua compiendo ampie spazzolate laterali con il becco semiaperto per intercettare prede (pesciolini, crostacei, anellidi, insetti acquatici). Foraggia singolarmente o in piccoli gruppi; la selezione micro-habitat dipende da profondità, torbidità e densità di prede.

Ciclo vitale e riproduzione
La Spatola è coloniale; nidifica spesso in associazione con ardeidi e gabbiani su isolotti, canneti fitti o alberi in zone umide costiere e interne. La stagione riproduttiva in Europa va in genere da marzo ad agosto; la covata (3–5 uova) è incubata da entrambi i sessi per ~21 giorni; i giovani diventano volatori in ~7 settimane e vengono nutriti tramite rigurgito. La fedeltà al sito è elevata laddove il disturbo è minimo e l’offerta trofica costante.
Distribuzione e popolazioni
La sottospecie nominale P. l. leucorodia occupa l’Europa occidentale e centrale fino all’Asia occidentale; altre sottospecie (balsaci, archeri) sono localizzate in Mauritania/Capo Verde e Mar Rosso/Golfo di Aden. In Europa, popolazioni chiave si trovano nel Wadden Sea, in Paesi Bassi, Francia atlantica, Penisola Balcanica e bacino danubiano; importanti quartieri di svernamento lungo le coste mediterranee e nord-africane. Tendenze recenti indicano recuperi locali grazie a protezioni delle zone umide e gestione dei siti.
Migrazione e rotte
Specie parzialmente migratrice: le popolazioni più settentrionali e continentali sono migratrici a media/lunga distanza; quelle atlantiche e mediterranee in parte sedentarie o a corto raggio. Le principali flyway AEWA includono:
- Rotta occidentale: colonie nord-europee → Penisola Iberica/Marocco e costa atlantica africana (es. Banc d’Arguin, Mauritania).
- Rotta centro-mediterranea: Europa centrale/balcanica → bacino mediterraneo (Italia compresa) e Nord Africa.
Stop-over cruciali sono estuari, lagune e saline con acque basse e alta produttività.
Minacce e conservazione
Le minacce principali sono perdita/degrado degli habitat umidi, disturbo in colonia, collisioni/elettrocuzione con linee elettriche e inquinamento; risentono anche della riduzione della risorsa trofica (es. pesca a strascico in laguna, variazioni idrologiche). La specie beneficia di aree protette Ramsar/Natura 2000, di action plan internazionali (AEWA, 2008) e di misure locali (controllo del disturbo, gestione idraulica, isole artificiali di nidificazione).
La Spatola in Sicilia
Presenza storica, fenologia e trend
La Sicilia è lungo un corridoio migratorio chiave del Mediterraneo centrale e ospita contingenti in migrazione primaverile e autunnale, oltre a svernanti regolari in alcune zone umide costiere e interne. La prima nidificazione accertata in Sicilia è stata documentata nel 1988; da allora la presenza è aumentata grazie a una rete crescente di aree protette e al recupero di popolazioni sorgente europee. In documenti tecnici nazionali è riportata la ricolonizzazione recente della Sicilia con ~11 coppie nidificanti (dato riferito agli anni successivi al 2010). Serie storiche regionali mostrano picchi di passaggio tra marzo–giugno (massimi a fine aprile) e numeri variabili nel resto dell’anno. Regione SiciliaMinistero Infrastrutture Trasporti
Uno studio di sintesi regionale (1972–2018) evidenzia che l’aumento in Sicilia è dovuto alla crescita delle popolazioni nidificanti dell’Europa centro-orientale e al miglioramento gestionale delle zone umide isolane; la Sicilia funge sia da area di sosta sia da quartiere di svernamento di rilevanza nazionale.

Siti principali e uso dell’habitat
Tra i siti più importanti per sosta/svernamento e, in anni recenti, riproduzione episodica o nelle vicinanze, si segnalano:
- Pantani della Sicilia sud-orientale (Vendicari, Marzamemi/Longarini): vaste superfici di acque basse e salmastre, alta produttività. Ministero Infrastrutture Trasporticaiscuola.cai.it
- R.N.O. Saline di Priolo (Siracusa): stop-over e svernamento regolare; contesto gestito (LIPU) con ripristino ambientale e controllo del disturbo. Lipu ODV
- Lago di Pergusa (Enna): zona umida endoreica interna, importante sito di passaggio/sosta per acquatici; ZPS/SIC della rete Natura 2000.
- Lago Biviere di Gela (Caltanissetta): Lago costiero naturale, importante siti di passaggio/sosta per anatidi, limicoli e trampolieri. Oasi Lipu.
Finestra temporale e numeri
Nel complesso regionale la specie è più frequente in primavera (marzo–giugno, con massimi a fine aprile) e meno tra luglio–settembre; svernanti presenti in alcuni anni nelle saline e lagune costiere. Le fluttuazioni locali tra siti siciliani riflettono condizioni idrologiche e disponibilità trofica; non emergono correlazioni semplici con la sola piovosità.
Gestione e priorità in Sicilia
Le misure efficaci includono:
- Mantenimento di livelli idrici idonei (acque basse, 10–40 cm) nelle vasche e nei piani tidali;
- Zone di rifugio a disturbo nullo in periodo riproduttivo e durante i picchi migratori;
- Isole/artificiali di nidificazione e gestione della vegetazione per canneti compatti;
- Corridoi ecologici tra saline, foci fluviali e pantani;
- Monitoraggi coordinati con AEWA/ESIEG e reti nazionali (LIPU, ISPRA) per quantificare trend e sopravvivenza.

Sintesi
La Spatola bianca è un indicatore della qualità ecologica delle zone umide. In Sicilia il suo incremento è un caso scuola di come protezione, ripristino e gestione adattativa possano favorire specie coloniali sensibili al disturbo. Il mantenimento della connettività tra i siti isolani e le rotte euro-mediterranee, insieme al contenimento delle pressioni (bonifiche, disturbo, inquinanti), resta cruciale per la resilienza a lungo termine delle popolazioni.
Fonti
BirdLife International. Species factsheet: Eurasian Spoonbill (Platalea leucorodia) (consultato 2025). BirdLife DataZone
IUCN Red List. Platalea leucorodia – valutazione globale e minacce (consultato 2025). iucnredlist.org
AEWA (UNEP). International Single Species Action Plan for the Conservation of the Eurasian Spoonbill (2008) e materiali associati. unep-aewa.org+1
RSPB – Spoonbill: ID ed ecologia (UK overview). rspb.org.uk
Regione Siciliana. Relazione avifauna (prov. di Messina) – fenologia regionale e prima nidificazione (1988). Regione Sicilia
MASE – Quadro conoscitivo Uccelli d’Italia (nota su ricolonizzazione e stima coppie in Sicilia). Ministero Infrastrutture Trasporti
Massa et al. (2020). La Spatola in Sicilia: 1972–2018, distribuzione ed ecologia (sintesi). iris.unipa.it
Studi su alimentazione/foraggiamento: Veen et al. 2012; Ardea 2012; analisi comportamentali. zoology.ubc.cabioone.org
Documentazione siti chiave Sicilia: Vendicari/Pantani e Saline di Priolo (Natura 2000, LIPU, divulgazione tecnica).